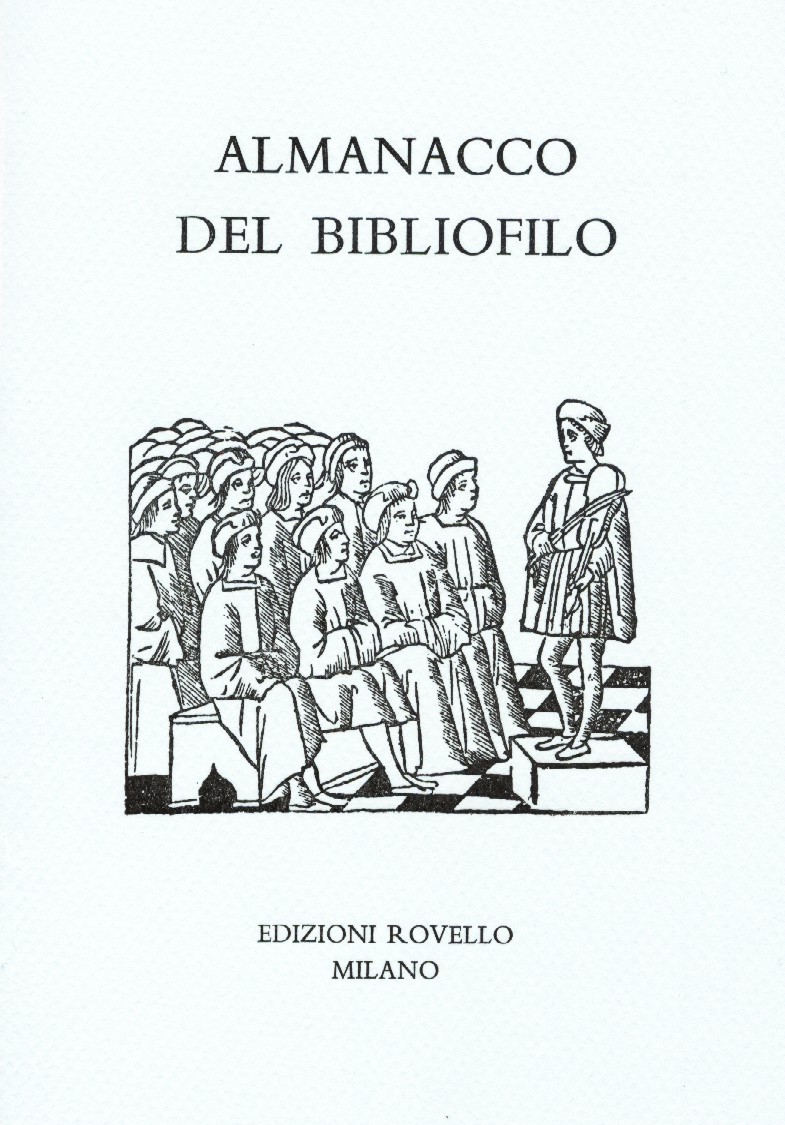JOSEF ŠVEJK, IL
BUON SOLDATO
di
Paolo Albani
«Una grande epoca
esige grandi uomini. Vi sono
degli eroi
ignorati e oscuri… l’esame della cui indole darebbe ombra perfino alla
gloria d’Alessandro Magno. Oggigiorno si può incontrare per le
vie
di Praga un uomo trasandato, che non sa quanta importanza abbia avuto
la
propria opera nella storia di un’epoca grande e nuova come questa. Egli
percorre tranquillamente la sua strada, senza che nessuno gli dia noia
e senza dar noia a nessuno, e senza essere assediato da giornalisti che
gli chiedano un’intervista. Se gli domandate come si chiama, vi
risponderebbe
con l’aria più semplice e più naturale del mondo: “Io son
quello Švejk…”»
Sono parole dello scrittore ceco Jaroslav Hašek, dadaplebeo e
«padre dei poveri di spirito», parole prese a prestito per
introdurre la figura di Josef Švejk, un uomo pacato e spontaneo: il
disegnatore
Josef Lada lo raffigura di bassa statura, con la barba incolta, una
pancia
dirompente e il naso bitorzoluto, segno evidente del suo amore per
birrerie,
mescite e cantine d’ogni ordine, specie quella chiamata «Al
calice»
in via Na Bojišti a Praga (in questo simile a Hašek che, come annota
contabilmente
Ripellino, frequentò più di cento bettole praghesi).
Il nostro Švejk, che non appartiene a nessuna confessione, ha una
faccia
di luna piena, gli occhi azzurri buoni e uno sguardo caldo e morbido da
agnello; di solito indossa un giubbone rattoppato sui gomiti, unto e
bisunto,
mentre i calzoni militari gli stanno addosso come la tunica di un
pagliaccio
da circo, e il berretto gli cala giù fino alle orecchie
grandi.
Così agghindato ha «l’aria di un dio delle malefatte
greco».
Švejk è la semplicità d’animo in persona. Da par suo
si muove egregiamente nel ruolo del candido che non si strugge di
fronte
ai discorsi complicati, ampollosi: «È una brutta cosa -
dice
- quando uno, tutt’a un tratto, comincia a confondersi la testa a forza
di filosofare; la cosa puzza sempre di delirium tremens».
Non di meno Švejk è perseverante e eroico, il suo nome al tempo
dell’Austria era sulla bocca di tutti i cittadini del Regno di Boemia e
la sua gloria, pronostica Hašek, non tramonterà neppure sotto la
Repubblica, e in effetti non è mai tramontata e resiste ancora
oggi,
candida e sfolgorante.
In ogni parte del mondo (le sue avventure sono state raccontate
in quasi tutte le lingue europee, e persino in giapponese e in coreano;
un frammento dell'opera che narra le sue gesta è stato tradotto
anche in latino con il titolo Res gestae boni militis Švejk.
Quomodo
bonus miles Švejk in Bellum Gentium attigit), Josef Švejk è
conosciuto con l’appellativo di «buon soldato».
Ciò dipende dal fatto che, dopo varie peripezie, Švejk fu
arruolato
nell’esercito imperiale austriaco durante la prima guerra mondiale,
esattamente
nel 91° reggimento di fanteria di guarnigione a Ceské
Budejovice.
Il motto di Švejk era: «Servire l’imperatore fino a rompersi le
ossa».
Quanto al termine «buono», dobbiamo andarci cauti, ma non
c’è
dubbio che esso indica la natura ingenua, paciosa di Švejk che non hai
mai l’abitudine di nascondere agli altri i propri pensieri,
virtù
unita a una certa dose di ottimismo, di solidarietà umana e a
una
forma di astuzia tipicamente contadinesca.
A dire il vero, prima del suo arruolamento, Švejk era stato riformato
dall’esercito perché ritenuto un idiota notorio, un idiota
secondo
tutte le leggi di natura, quelle inventate dai grandi maestri della
psichiatria
(in ceco il sostantivo «cretino» prende la forma bizzarra
di
«blb», un «groppo di labiali che stringono come due
guitti
una povera liquida», riprendendo una bella immagine
ripelliniana).
Il collegio di tre periti che visitò Švejk stese una relazione
rimessa al giudice istruttore in cui si consigliava di mandare il
«buon
soldato» in osservazione in una clinica psichiatrica per
determinare
fino a che punto il suo stato mentale poteva recare danno alle persone
che lo avvicinavano.
La cosa sorprendente è che dei pochi giorni trascorsi in
manicomio
Švejk conservò un buon ricordo. Sono stati - raccontava quasi
commosso
- «fra i più bei momenti della mia vita», e non si
tratteneva
dal parlare in termini entusiastici della vita in manicomio:
Non riesco
proprio a capire perché i
pazzi s’arrabbino
a stare rinchiusi. Lì la gente può rotolarsi in terra
tutta
nuda, urlare come uno sciacallo, far le furie e dar morsi. Se si
facesse
qualcosa di simile a passeggio, tutti resterebbero stupefatti;
lì
invece è la cosa più naturale del mondo. Là dentro
c’è tanta libertà, che non se la sognano nemmeno i
socialisti.
Dal manicomio Švejk uscì
con un certificato da cui
risultava
che era «un simulatore debole di mente» (anche Hašek ha
conosciuto
il manicomio, una sera che voleva gettarsi dal Ponte Carlo e affermava
di essere Ferdinando il Buono). In seguito Švejk fu accusato di essere
un «volgarissimo disertore» e si arriverà persino a
sospettarlo di fare la spia per i russi, ma se la caverà sempre
bene, sia pure ogni volta sul filo del rasoio.
Nonostante i reumatismi e i gonfiori alle ginocchia, Švejk venne
richiamato
alle armi dopo l’assassinio dell’arciduca Ferdinando e diventò
attendente,
prima del cappellano militare Otto Katz, un ubriacone di origine
ebraica
cui piaceva ogni tanto fare un pokerino e ospitare a casa sua delle
ragazze
di strada, poi del tenente Lukáš, il prototipo dell’ufficiale di
carriera dell’impero austroungarico, uno dei pochi ufficiali giusti che
godeva di una grande popolarità fra i soldati e che non aveva il
costume di perseguitare nessuno.
Il tenente Lukáš era un amante dei cani e guarda caso fra le
attività svolte da Švejk prima della guerra (per qualche tempo
aveva
lavorato come apprendista in una drogheria da cui fu licenziato
perché
dette fuoco per sbaglio, nello scantinato del negozio, a un fusto di
benzina)
c’era quella di commerciante di cani (come Hašek, del resto).
Quando viveva del traffico di cani non si può dire che Švejk
abbia seguito i canoni di una irreprensibile deontologia. Aveva fatto
stampare
dei pedigree con cui riusciva a mutare un cagnaccio di sobborgo, nato
in
una fornace, in uno dei più rari esemplari usciti dal canile
dell’allevatore
bavarese Armin von Barheim. Era capace di rifilare alla gente un
cagnetto
di Vérsciovize, peloso e con le gambe per niente corte, per un
bassotto.
Se volete vendere un cane inoltrato negli anni per un cucciolino -
suggeriva Švejk - dovete prendere un po’ d’argento vivo, farlo fondere
e ridipingere il cane tutto nero così che sembri nuovo; per
ridargli
forza nutritelo come un cavallo con dosi di arsenico e lustrategli la
dentatura
con della carta vetrata, e prima di portarlo dall’acquirente fategli
inghiottire
un grappino, perché si riscaldi e diventi allegro e vivace.
Al tempo in cui Švejk faceva il commerciante di cani si stampava una
rivista di zoologia intitolata Il mondo degli animali (vi
collaborò
anche Hašek) su cui comparve un allegro bestiario, redatto usando una
terminologia
scientifica inconsueta, dov’erano menzionati topi muschiati, pulci
preistoriche,
balene dalla pancia sulfurea e cuccioli di lupi mannari.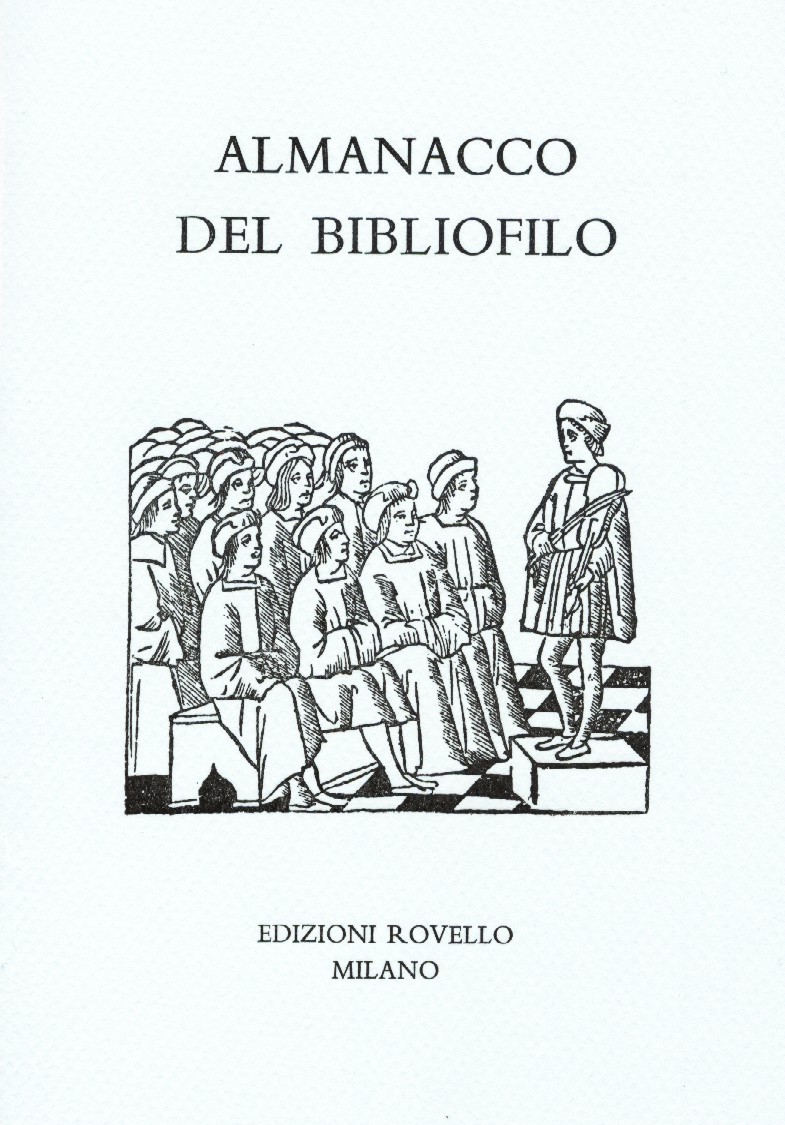
L’indole cicaliera del buon
soldato Švejk lo porta a
insaporire i propri
discorsi, regolarmente preceduti come vuole il regolamento militare
dalla
frase in tedesco «Ich melde gehorsam» (Faccio
rispettosamente
notare), con delle storielle intriganti. Švejk ha sempre una provvista
di casi da raccontare, è un fabulatore disincantato, un
collezionista
di aneddoti sgangherati che riguardano personaggi stralunati, gente
semplice
e reietta.
È con gran dovizia di particolari che Švejk racconta le sue
storielle, come quella di una maestrina praghese che s’innamorò
di un cameriere negro, il cui padre era un re abissino; dal cameriere
negro
la donna ebbe un figlio che, all’inizio, le nacque completamente
bianco,
ma dopo un mese prese a diventare nero; allora la donna lo portò
in una clinica per malattie della pelle per farlo stingere, ma le
dissero
che non c’era niente da fare, la pelle del bambino era proprio pelle
nera
da africano, e così la poveretta ne uscì pazza, e
cominciò
a chiedere a varie riviste cosa si poteva fare per scolorire i negri, e
alla fine dovettero portarla alle «Caterinette», una
clinica
praghese per alienati mentali.
O la storia di quel carbonaio imputato di alto tradimento che ad ogni
interrogatorio rispondeva sempre con la medesima filastrocca:
«Sia
pure come sia, in qualche modo sia, / ancora non c’è stato che
in
nessun modo è stato», tiritera che ripeté, sembra,
anche sotto il capestro. O ancora la storia di una donna accusata di
aver
strangolato i suoi due gemelli nati da poco, che però giurava
che
non avrebbe potuto strangolare due gemelli dato che le era nata
soltanto
una bimba, che aveva strangolato, senza però farla soffrire;
nonostante
questa precisazione, venne condannata per duplice infanticidio.
Un’altra storia toccante raccontata da Švejk ha per protagonista una
sirena marina esibita da un certo Mestek dietro un paravento in piazza
Havlícek nel quartiere Vinohrady di Praga. Il paravento aveva
un’apertura
da cui, a condizione si fosse compiuto sedici anni e pagato il
biglietto,
si poteva scorgere nella semioscurità un comunissimo divano sul
quale si contorceva una femmina con le gambe avvolte in un velo verde
che
doveva rappresentare la coda, i capelli verniciati di verde e le mani
fasciate
da guanti sui quali erano state applicate delle pinne di cartone,
anch’esse
verdi; sulle spalle c’era un’altra specie di pinna direzionale, fissata
con uno spago. La sirena aveva un grosso sedere sul quale si leggeva la
scritta A rivederci! I seni le calavano giù fino
all’ombelico
come accade alle vecchie baldracche. Finita l’esibizione, alle dieci di
sera la sirena si trasferiva in via Táborksá dove,
passeggiando,
diceva con aria indifferente a ogni signore che incontrava: «Bel
signore, andiamo a fare l’amore?»
Linguacciuto, birroso, maldestro
e con un’infrenabile
parlantina da
bettola (Ripellino), il buon soldato Švejk possiede un che di
tristemente
clowenesco nel suo comportamento e di malizioso (sedizioso) allo stesso
tempo, la sua innocente cretineria, il suo fingersi idiota sono quanto
di più sgretolante si possa dare contro gli ingranaggi assurdi
della
guerra e l’arroganza dei suoi fautori, contro «la friabile
argillosità
delle istituzioni ufficiali».
Almanacco del Bibliofilo,
20, 1 gennaio 2010, pp.
23-30.
Questo numero dell'Almanacco, intitolato "I ragazzi di via
Rovello",
a cura di Mario Scognamiglio, contiene testi di (in ordine di
apparizione)
Umberto Eco, Paolo Albani, Annalisa Bruni, Arturo Capasso, Salvatore
Carrubba,
Gianni Cervetti, Matteo Collura, Gianandrea de Antonellis, Oliviero
Diliberto,
Gianfranco Dioguardi, Curzia Ferrari, Mauro Giancaspro, Giuseppe
Marcenaro,
Antonio Mereu, Maurizio Nocera, Elio Palombi, Mario Scognamiglio,
Pietro Spirito, Armando Torno.
Per ritornare al sommario dell'Almanacco del Bibliofilo cliccate
qui.
HOME
PAGE TèCHNE
RACCONTI
POESIA VISIVA
ENCICLOPEDIE
BIZZARRE ESERCIZI
RICREATIVI NEWS
|