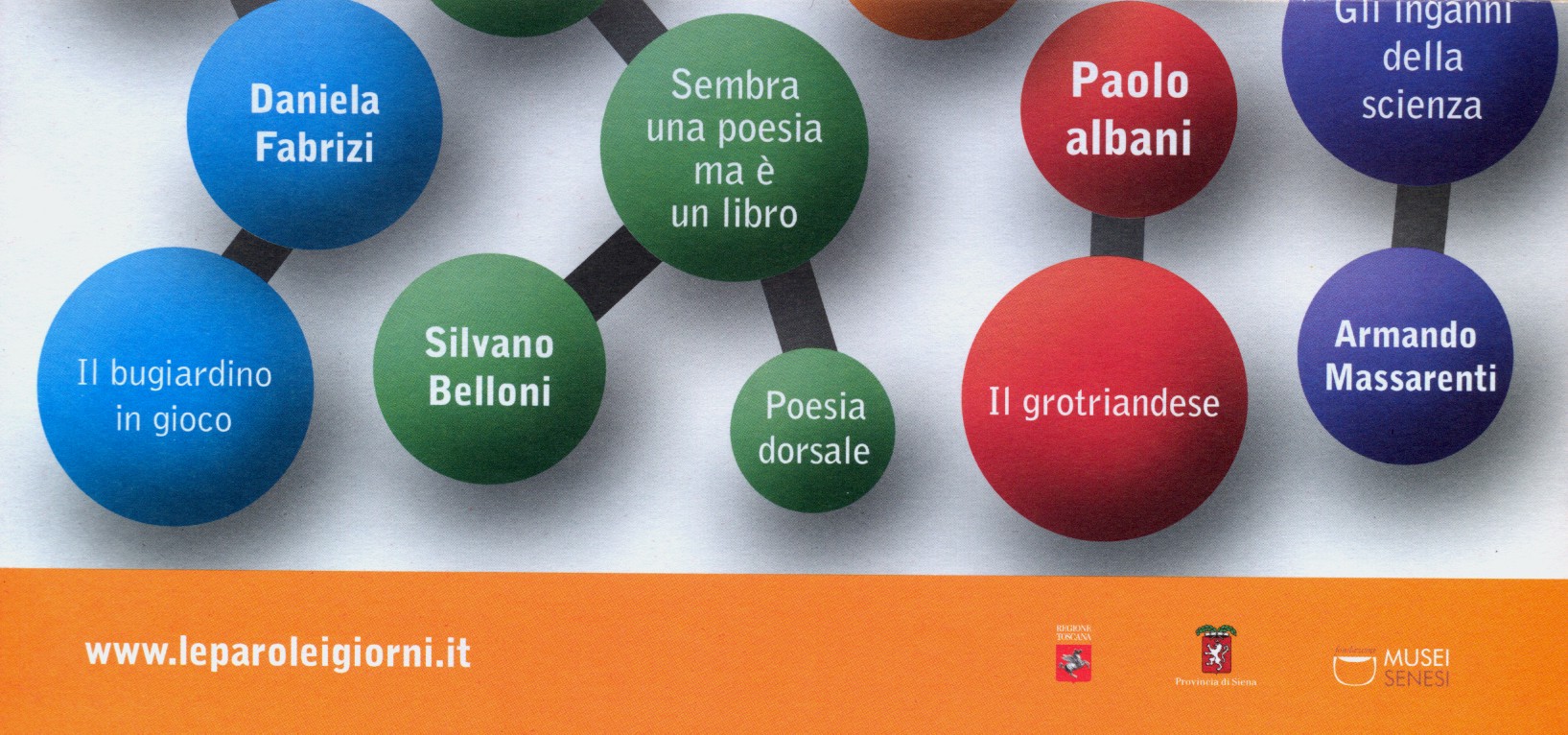Paolo
Albani
IL GROTRIANDESE

Fra i precursori
dell'antropologia culturale, la cui fondazione
come scienza autonoma si fa generalmente risalire al 1871, anno in cui
uscirono i lavori pionieristici di L.H. Morgan e E.B. Tylor, non sempre
viene ricordato il nome del polacco Stefan Norwid, un
esploratore audace, tedesco per parte di madre, un uomo dal fisico
asciutto,
alto non più di un metro e quarantadue centimetri, che pure
ostentava,
nonostante la statura poco lusinghiera (lo testimonia un suo ritratto
custodito
nel palazzo del Belvedere di Varsavia), uno sguardo altezzoso e un
ghigno
oltremodo insolente sforbiciato in mezzo al cespuglio ispido della
barba
rossiccia.
All'inizio del secolo XIX Norwid (che poco prima di morire ebbe
modo di conoscere Malinowski e d'intrattenere con lui un breve, ma
intenso
rapporto epistolare) scrisse un documento quanto mai interessante: un
diario
sugli usi e costumi degli abitanti delle Grotriand, una serie di isole
coralline situate nell'oceano Pacifico, in un lembo sperduto di mare
fra
le Filippine e la Nuova Guinea.
L'esploratore polacco fu uno dei primi a entrare in contatto
con i Grotriandesi, una popolazione negroide, organizzata in clan
esogamici
(il coniuge viene scelto al di fuori del proprio gruppo di parentela o
socioeconomico) matrilineari e, come tutte le popolazioni isolane che
vivono
in quell'area del Pacifico, dedita principalmente all'agricoltura
(tuberi),
all'allevamento (maiali, usati anche per sacrifici rituali) e alla
pesca
(soprattutto quella perlifera); un'altra attività praticata dai
Grotriandesi è la caccia agli uccelli le cui piume sono
impiegate
per decorazioni personali e in vere e proprie produzioni artistiche.
Con la sua spedizione, di cui facevano parte cinque membri (un
medico naturalista, tre mozzi e un cuoco), Norwid sbarcò a
Pukal,
la più appartata e minuscola delle isole Grotriand, il 21 giugno
del 1823 e vi soggiornò per circa quattordici mesi, accampato ai
margini del villaggio di una tribù che lo accolse
amichevolmente.
Gli indigeni di Pukal, che non avevano mai visto un bianco, dettero a
Norwid
il nomignolo di ghai kol, cioè «figlio della brace
incandescente», per via del colore rossiccio della sua folta
capigliatura.

Gran parte del diario di Norwid è dedicata a una minuziosa
descrizione del linguaggio dei Grotriandesi che, analogamente alle
parlate
degli indiani d'America e dei Papua, si basa su «un sistema di
articolazioni
spericolate, nasalizzazioni, stiramento di muscoli, toni rauchi, suoni
apicali, sillabe strascicate e note in falsetto alte soprattutto nella
seconda o terza sillaba».
Una delle caratteristiche più significative del linguaggio
grotriandese, osserva Norwid, è la sua estrema ambiguità,
la sua polisemia. Poiché uno stesso termine in grotriandese ha
molti
significati - ad esempio fratiak può significare
«stupido»,
«sagace», «mezzacalzetta»,
«stuzzicante»,
«chiacchierone», «perdigiorno»,
«irresistibile»,
«porco», «rubacuori», «pianta
grane»,
«ladro di serpenti», «pancia che gorgoglia»,
ecc.
- i Grotriandesi hanno una forte predisposizione verso i giochi con le
parole, atteggiamento che si traduce in una smisurata, assidua
creazione
di indovinelli, filastrocche, canti con doppi sensi, alcuni dei quali a
sfondo erotico.
C'è un canto molto noto nell'isola di Pukal, un canto
gestuale accompagnato da movimenti ritmici e grida improvvise, dedicato
a Mitrasil, dio della fecondazione. In grotriandese il termine mitrasil
significa letteralmente «Prendimi con dolcezza e fammi
tua»,
ma cambia completamente di significato qualora sia rivolto, in un
contesto
di vita quotidiana, a un consanguineo di sesso femminile; in
quest'ultimo
frangente, mitrasil indica una richiesta ben precisa, ovvero:
«Prendimi
la noce di cocco che sta ai piedi dell'albero».
La stessa espressione - «Padi ting gud foh»
- viene usata dai Grotriandesi in circostanze diametralmente opposte:
da
un lato essa significa «Ah, finalmente, eccoti qua!», nel
momento
in cui due individui s'incontrano in uno spazio aperto o dentro una
capanna;
dall'altro il valore semantico di «Padi ting gud foh»
si trasforma in: «Ciao, devo scappare, ci vediamo presto»,
quando due individui si congedano, al termine di una conversazione
svoltasi
in prossimità del mare, accompagnata dal fruscio melodico delle
onde.
Per dare risposte affermative i Grotriandesi sono soliti chiudere
gli occhi e sospirare, scandendo lentamente la parola lufigiac
che,
esibita in questo modo, equivale a un netto «sì»,
«d'accordo»,
«va bene»; per le negazioni, invece, i Grotriandesi si
comportano
altrimenti: restano con gli occhi aperti, guardando dritto in faccia il
loro interlocutore, e esclamano, rapidi e decisi, lufigiac,
così
da evitare ogni fraintendimento.
Una delle imprecazioni più diffuse fra i Grotriandesi
è «Pegh roa niat serli» che, pronunciata
puntando
il dito indice verso qualcuno, significa all'incirca «Che il
cielo
possa abbassarsi fino a schiacciarti la punta del naso». La
stessa
frase, detta allargandosi in un sorriso che lasci ben scoperta la
dentatura
frontale, bianchissima, e ponendo le mani sui fianchi, assume un altro
significato, e cioè «Che Lugim possa trasportarti
in
cielo e cullarti fra le sue braccia di nuvole», dove Lugim
è il dio grotriandese del vento, uno dio buono che aiuta le
persone
a sollevarsi, sia fisicamente che mentalmente.
«Ben presto ho scoperto a mie spese», annota Norwid
nel suo diario il 3 settembre 1823, «che bisogna fare attenzione
a rivolgersi a un Grotriandese con la frase "Nuga rid blanfesa".
Infatti, prima che il sole sia tramontato dietro il profilo delle
montagne
sempreverdi o del cono minaccioso dell'unico vulcano dell'isola o
ancora,
a seconda della visuale dell'osservatore, dietro la linea
dell'orizzonte
che unisce il cielo e il mare in un abbraccio struggente, la frase
significa
"Ti sei alzato bene, oggi?"; al contrario, dopo il tramonto, la stessa
locuzione "Nuga rid blanfesa" si veste di un contenuto
apertamente
ostile, poco affettuoso, e cioè: "Che fai ancora qui. Vattene a
dormire, fannullone!"»
«Un giorno», scrive Norwid il 7 aprile 1824,
«me
ne stavo seduto sopra una pietra, da solo, immerso non ricordo
più
in quali pensieri, all'ombra di un banano per mitigare i vapori del
grande
caldo, quando d'un tratto un piccolo grotriandese, seminudo, mi
passò
accanto di corsa e mi urlò: "Karilù, ghai kol".
Più
tardi chiesi a un anziano il significato della parola "karilù"
che non avevo mai sentito. Per tutta risposta, questi mi chiese se il
bambino
portava una piuma in testa, perché, se per caso non la portava,
si era semplicemente limitato ad augurarmi: "Buona giornata, figlio
della
brace incandescente!"; se invece aveva una piuma infilata fra i
capelli,
stretta da un laccio sottile, allora: "La parola karilù",
mi disse il vecchio ridacchiando sotto una lunga barba bianca cui erano
appese delle conchiglie a forma di spirale, "non si può
ripetere,
da quanto è sconcia"».
Prima di entrare in una capanna grotriandese è buona
regola
fermarsi sulla soglia della porta, battersi il petto due volte con la
mano
destra in segno di amicizia e chiedere a voce alta: «Puca lo?»
(È permesso?). A questo punto, dall'interno della capanna, vi
risponderanno
«Tet mua fri» (Avanti, prego) oppure «Tet
mua
fri» (Ripassate più tardi, siamo occupati), a seconda
che «Tet mua fri» sia seguito o meno da una leggera
eruttazione.
Lo stregone della tribù dell'isola di Pukal, quando deve
guarire qualcuno dall'influsso negativo degli spiriti, si cosparge il
volto
con una specie di cipria biancastra e indossa un gonnellino di piume di
cacatua, che gli nasconde appena un minuscolo perizoma; poi comincia a
recitare questa formula: «Abo hughi romta bu lapinaciò»,
danzando freneticamente intorno al poveretto, al suono ossessivo di un
tamburo, roteando in alto una lancia da cui pendono dei nastrini
colorati.
Il rito si protrae a volte per una giornata intera, fino a quando
entrambi,
lo stregone e il posseduto dallo spirito maligno, non cadono a terra
sfiniti
e vengono portati a braccia nelle rispettive capanne.
A proposito dello stregone della tribù dell'isola di
Pukal,
Norwid racconta questo episodio. Un giorno, al ritorno di
un'esplorazione
dentro una grotta situata ai piedi del vulcano, Norwid passò
vicino
alla capanna dello stregone e lo sorprese mentre ripeteva la formula
magica:
«Abo hughi romta bu lapinaciò». Era l'ora di
pranzo e, in un'enorme scodella di legno, lo stregone si stava
preparando
il sepikab, un piatto tipico grotriandese costituito da un
intruglio
di erbe aromatiche tagliuzzate fini e mescolate con una bevanda
liquorosa.
Le capanne del villaggio dove vive la tribù dell'isola
di Pukal sono disposte in modo da formare una figura ovale, e questo
non
a caso perché l'uovo è il simbolo grotriandese della
prosperità.
Ai bordi del villaggio, sparsi qua e là, ci sono dei magazzini
eretti
su palafitte. Nei punti estremi dell'ovale, s'innalzano poi due pali di
circa tre metri, intagliati magistralmente, identici in tutto e per
tutto
fra loro. Entrambi raffigurano la testa di un serpente con la lingua
biforcuta;
al posto degli occhi, il serpente ha due gusci di cocco spaccati a
metà,
dipinti di nero; dalla testa si allunga un corpo squamoso munito di
larghe
ali, simili a quella di un'aquila. Il palo posto a nord del villaggio
è
consacrato al dio della pazienza, «Perisol», che
è
anche il protettore, lo spirito custode della tribù; nel palo
situato
a sud, invece, i Grotriandesi venerano un altro dio, «Perisol»,
che impersona l'inarrestabile energia della natura, un dio
suscettibile,
capriccioso, che quando si arrabbia, per il minimo disappunto, rovescia
sull'isola terribili uragani e a cui, per placarne l'ira, a ogni cambio
di luna, i Grotriandesi offrono in sacrificio una scrofa vergine, il
cui
sangue viene cosparso sulla bocca del serpente.
La morale dei Grotriandesi, se così possiamo esprimerci,
s'ispira a un princìpio elementare, che possiede la forza
travolgente
e persuasiva di un aforisma zen: per un Grotriandese è
«bene»
(«otalim») tutto ciò che si accorda in modo
armonioso
al colore inconfondibile delle perle; è «male»
(«otalim»)
tutto il resto.
gennaio 2005
Una versione ridotta di questo racconto è uscita su il
Caffè illustrato, 24, maggio-giugno 2005, p. 12.
Per andare al sommario de il Caffè illustrato cliccate
qui.
_____________________________________
Il racconto è uscito anche in
La governante di Jevons. Storie di precursori
dimenticati, Campanotto 2007.
________________________________________
Sul linguaggio dei Grotriandesi
ho fatto un intervento
al Festival Le parole, i
giorni, a cura di Maria Perosino e Stefano Bartezzaghi, nella Sala minore del Teatro Politeama di
Poggibonsi
(Siena) il 16 aprile 2010.
HOME
PAGE TèCHNE
RACCONTI
POESIA
VISIVA
ENCICLOPEDIE
BIZZARRE ESERCIZI
RICREATIVI NEWS
|